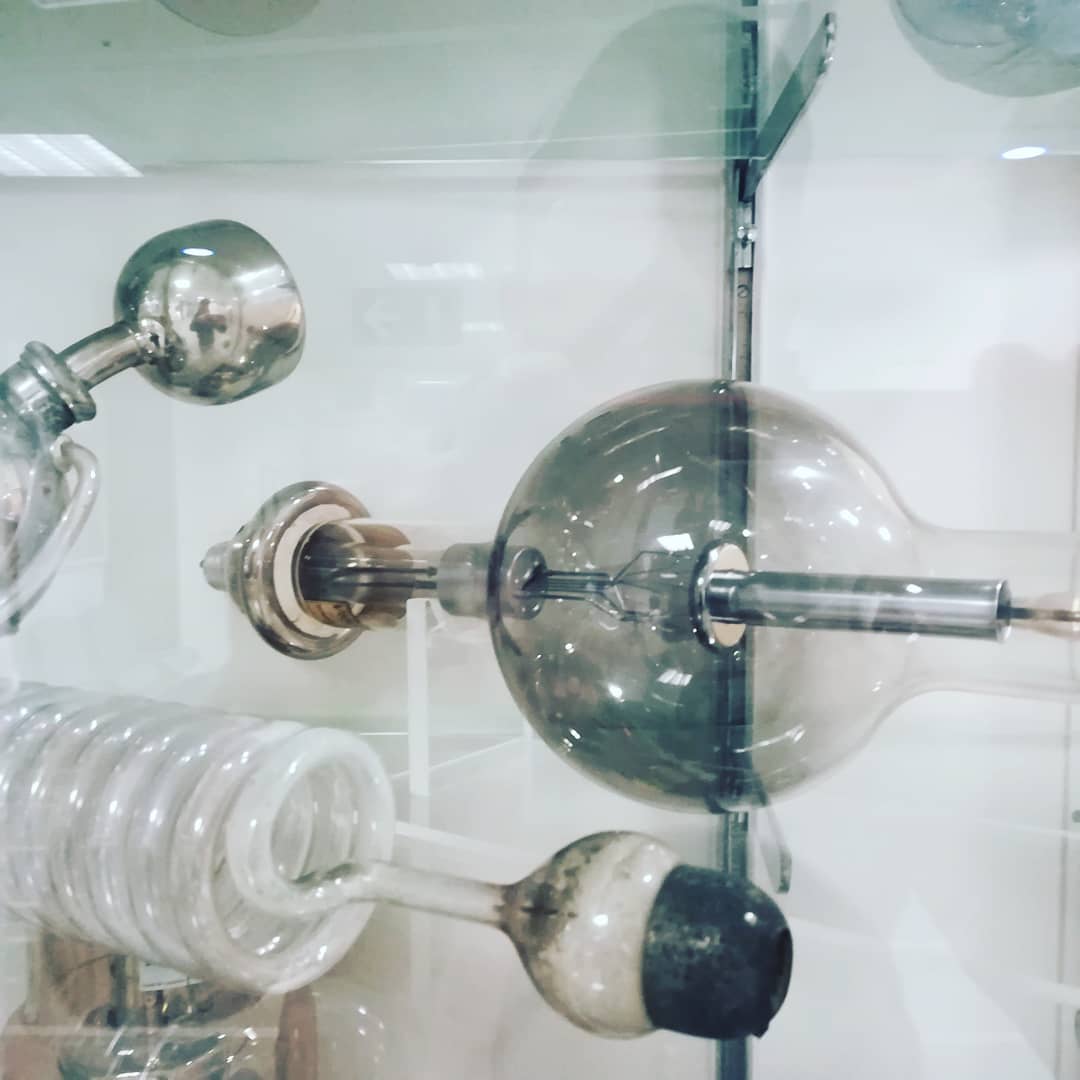“Distopia is the new oppio dei popoli”.
[L’audio del mio corsivo andato in onda su Rete Due lo potete ascoltare qui]
Fateci caso: i racconti distopici, nella loro versione cartacea o nelle grandi produzioni cinematografiche e seriali sono dappertutto, sono ormai diventate un aspetto inaggirabile della cultura popolare.
Oramai saturano la quotidianità di tutti o – quantomeno – quella di una classe media intellettuale senza fiato, schiacciata tra la sua sempre maggiore irrilevanza e l’assenza di un progetto per un futuro migliore.
La distopia infesta le nostre pause caffè e le nostre riflessioni etiche da apericena.
Ci diciamo a vicenda quanto sia inquietante la realtà futura che ci propongono gli sceneggiatori di “Dark mirror” o di “Handmaid’s tale”, e di quanto essa appaia in realtà vicina a quello che già stiamo vivendo.
Ma come è potuto accadere che la distopia, un genere letterario conosciuto fino a pochi anni fa da una nicchia di appassionati (e che anzi non era nemmeno un genere a sé ma una delle tante correnti nel grande mare della fantascienza) diventasse così popolare?
Mentre gli storici e i filosofi hanno studiato la genealogia delle utopie, oggi è quella delle distopie che andrebbe studiata, magari partendo da quella che più di altre ha contribuito a renderla popolare: parlo naturalmente di “Matrix”, film del ’99 dei fratelli Wachowsky.
E’ probabile che il successo del genere sia dovuto al fatto che esso rispecchi “l’esprit du siècle”; è dunque anche una chiave di lettura della realtà contemporanea.
C’è qualcosa che ha a che fare con il tempo, come ha cercato di spiegare Mark Fisher, critico musicale e filosofo, che nel suo libro “Realismo capitalista”, parlando del film “I figli degli uomini” (un’altra distopia) scriveva:
“Un tempo i film e i romanzi distopici erano esercizi di immaginazione in cui i disastri agivano come pretesto narrativo per l’emersione di modi di vivere nuovi e differenti”
Oggi invece esse sono un’esacerbazione del nostro presente più che una realtà alternativa vera e propria.
“Ultra autoritarismo e Capitale non sono in alcun modo incompatibili: i campi di internamento e le caffetterie in franchise coesistono in tutta tranquillità”, scriveva ancora Mark Fisher.
E’ quello che questo autore di culto, toltosi la vita nel 2017, chiama “Realismo capitalista”, la sensazione diffusa di un presente che si prolunga all’infinto senza possibilità di redenzione utopica, dove non esiste la scelta tra pillola azzurra o pillola rossa.
L’inquietudine vissuta per il racconto di un futuro ambiguo, spesso autoritario, non ci richiama all’impegno civile per costruire un futuro diverso, per evitare che la distopia diventi realtà.
Tutto sommato la nostra vita è lontana da quella degli sfortunati protagonisti di una puntata di “Dark mirror”. Così la distopia ci desensibilizza alla tristezza del presente.
E forse è proprio questa la sua funzione.